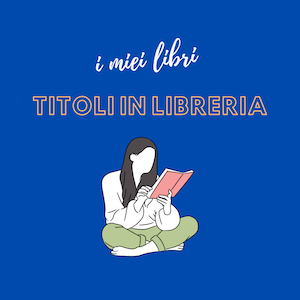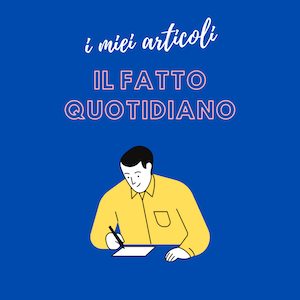Altre notizie dai nostri siti
 |
 |
 |
 |
 |
RESTIAMO IN CONTATTO!
PER CONOSCERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI VISITA LA MIA PAGINA FACEBOOK
La leggenda del Castelluccio
La Leggenda del Castelluccio di Gela parla di una bellissima castellana dalla lunga chioma nera che attirava tutti i passanti e i contadini con i suoi canti melodiosi.
Si narra che la bella castellana fosse di corporatura esile, che indossavsse un meraviglioso manto blu e argento, truccata con uno strano rossetto verde. Era una figura dotata di fascino misterioso perché tanto bella quanto crudele, severa e intransigente con i servitori, ambigua, sfuggente.
Durante le sue giornate si occupava della servitù e si prendeva cura dei cavalli.
Tanti uomini erano attratti dalla sua bellezza e dalla sua voce, ma chiunque tentava di avvicinarsi poi scompariva nel nulla.
Chi doveva discutere di affari con lei, inviava i messaggi con i piccioni. Ma anche quelli non facevano più ritorno.
Alcuni raccontano di aver visto di notte un cavaliere con l’armatura aggirarsi intorno alla fortezza, per poi scomparire nell’oscurità.
Questi strani eventi mettevano certamente paura ai numerosi viandanti che, spesso, evitavano di avvicinarsi troppo al castello.
Si racconta anche che fra quelle mura secolari del castello vi fossero dei fantasmi e ombre.
Si dice inoltre che ci fosse nascosto un tesoro ovvero “a travatura” ma finora nessuno è mai riuscito a trovarne traccia.
Non si sa se la Castellana sia veramente esistita in questo castello ma ciò che è vero è che all’interno del castello ci sono dei tunnel sotterranei che lo collegano fin dentro la città di Gela.
L'articolo La leggenda del Castelluccio proviene da Gela Le radici del Futuro.
I rami ‘che ficu
I “rami ‘che ficu” sono, a Gela, i più gustosi e tradizionali dolci di Natale.
Ingredienti necessari e peculiari sono i fichi essiccati durante l’estate.
Il ripieno di questi dolci noti e amati si ottiene con un impasto, appunto, di fichi secchi e vino cotto, anch’esso preparato durante il periodo della vendemmia.
Solitamente i “rami” sono ricoperti dalla “ghiacciata”, un composto emulsionato di zucchero a velo e albume.
Questi dolcetti, preparati quasi esclusivamente durante le festività natalizie, richiamano fortemente le antiche tradizioni.
Ingredienti:
-½ chilo di farina
-15 gr di lievito
-4 tuorli
-150 gr di strutto o burro
-250 gr di zucchero
-scorza di limone
-1 bustina di vanillina
Per il ripieno:
-200g fichi secchi
-150g mandorle
-buccia d’arancia
– 2 cucchiai di vino cotto o marsala
-un pizzico di cannella
Per la glassa:
-2 albumi
-100g di zucchero a velo
-succo di limone q.b.
-codette colorate per la decorazione
Preparazione:
Procedete sbollentando i fichi secchi, in acqua calda per un paio di minuti.
Tritare finemente i fichi secchi appena sbollentati con una lama ben affilata, se volete, potete anche usare un passaverdure.
In una pentola, versare i fichi secchi tritati, aggiungendo la scorza di un’arancia.
Unire al composto del vino cotto o del marsala e far cuocere a fiamma molto bassa per alcuni minuti.
Nel frattempo tritare le mandorle, possibilmente tostate, e aggiungerle al composto assieme, se volete, a una spolverata di cannella.
Mescolare fino a quando il composto sarà ben amalgamato, e poi, lasciatelo riposare per qualche ora.
Procediamo a questo punto a preparare la pasta frolla.
In una ciotola aggiungete alla farina la vanillina e il lievito per dolci. Incorporate lo strutto o il burro, e lavorate velocemente il composto. Aggiungete un pizzico di sale, la scorza di limone grattugiata e i tuorli.
Lavorate l’impasto fino a ottenere un composto omogeneo e liscio.
Avvolgere la frolla con della pellicola da cucina e lasciarla riposare in frigo per un’ora o anche più.
Trascorso questo tempo, procedete stendendo la frolla con l’ausilio di un mattarello, dandole una forma rettangolare.
Farcite adesso la frolla con il ripieno di fichi secchi.
Richiudete la frolla in modo da formare una specie di salsicciotto.
A questo punto, con un coltello, tagliate la frolla in modo da formare dei tronchetti di pasta, ricordandovi di fare, ai lati, le incisioni classiche dei “rami che ficu”
Infornare in forno preriscaldato a 200° sino a quando non si saranno dorati.
A questo punto, tirateli fuori dal forno e lasciateli raffreddare.
Nel frattempo che i “rami che ficu” si raffreddino, prepariamo la “ghiacciata”, ovvero glassa di zucchero.
Lavorate, mediante le fruste l’albume fino a quando vedrete che comincia a diventare bianco, stando attenti a non montarlo a neve.
Aggiungete, molto lentamente, lo zucchero a velo e qualche goccia di limone, mescolando con una spatola, sino a quando non otterrete una glassa bianca.
A questo punto, tramite un pennello, spennellate i “rami” con la glassa.
Aggiungete se volete delle decorazioni, io ho usato delle codette colorate.
Rimettete i “rami” nel forno caldo ma spento, per far si che la glassa si solidifichi.
I vostri “rami che ficu” sono pronti per deliziare il palato di grandi e piccini durante queste feste.
Buon appetito e buone feste!
L'articolo I rami ‘che ficu proviene da Gela Le radici del Futuro.
Tra sogni, scelte e radici: Cuori Lucani, la terza stagione
La web serie Cuori Lucani si presenta come una produzione sincera del territorio della Val d’Agri, capace di coniugare racconto personale, ambiente e identità lucana con uno sguardo capace di parlare anche oltre i confini.
Questa web serie, diretta da Iacopo Patierno, si compone di brevi episodi ciascuno dedicato ad un protagonista che vive nei territori della Val d’Agri.
Le prime 2 stagioni
Nella prima stagione i 7 episodi hanno raccontato la passione per il lavoro e per la propria terra attraverso i volti dei protagonisti, esplorando storie individuali che mettono al centro il rapporto con la terra, il lavoro e l’identità del territorio lucano. I 5 episodi della seconda stagione hanno avuto come filo conduttore la passione di aziende familiari che passano a nuove generazioni tra innovazioni e tradizioni che convivono, allargando lo sguardo non solo su chi ha scelto il “fare” sul territorio ma anche su chi eredita e rilancia, su come generazioni diverse mantengono vivo un legame con la propria terra e lo rinnovano.
La terza stagione
La terza stagione, composta da 5 episodi, ci porta a scoprire, attraverso sport come l’arrampicata, l’equitazione, la pesca sportiva, la mountain bike e il trekking, storie reali e genuine di passione, lontane dal glamour televisivo, che fanno percepire un filo comune che le unisce che è quello della volontà di restare, di far conoscere il proprio territorio, di far crescere qualcosa lì dove il resto del mondo spesso guarda altrove.
Anche questa terza stagione della web serie fa un grande uso del paesaggio lucano che diventa non semplice sfondo, ma parte integrante della narrazione, dello stile visivo e dell’identità dei protagonisti, e questo conferisce autenticità e fascino. Il formato breve e la concentrazione su un solo protagonista per ciascun episodio donano immediatezza; il tono “leggero” e quasi documentaristico, ne contraddistinguono chiarezza, genuinità e semplicità.
Sogni, scelte e radici
Cuori Lucani è una scoperta preziosa per chi ama le narrazioni autentiche, i luoghi meno conosciuti, senza effetti speciali o colpi di scena da blockbuster, senza spettacolarizzare sa emozionare con la quotidianità, con la bellezza discreta della terra lucana e con storie che, se pur locali, parlano di sogni, di scelte e di radici.
Ogni episodio è un piccolo ritratto, un battito di quel grande cuore collettivo che è la Val d’Agri, non ci sono attori ma persone vere, non ci sono scenografie ma paesaggi che respirano insieme ai protagonisti. Il risultato è un racconto che profuma di autenticità, di quella semplicità che troppo spesso si perde nella corsa del mondo. In ognuna di queste storie c’è qualcosa di universale, la passione per la montagna e le sue rocce, la sicurezza di saper montare a cavallo, la pazienza di chi pesca ai margini di un fiume, l’adrenalina di una discesa in mountain bike, la sensazione di benessere che ti regala una passeggiata nei boschi, l’amore incondizionato per la propria terra, il coraggio di restare, la voglia di costruire futuro dove gli altri vedono solo passato.
Cuori Lucani, una dichiarazione d’amore
Forse Cuori Lucani non è una serie nel senso tradizionale del termine, è più una dichiarazione d’amore alla terra, alle radici, ai sogni che crescono piano ma resistono, è la prova che anche con poco, un’idea e tanta verità, si può far fiorire un racconto: le montagne diventano spalle, i fiumi parole, il vento una voce che ti dice che restare non è immobilità ma scelta. Non serve conoscerla la Val d’Agri, basta guardare e ascoltare il suono antico che viene da quei cuori, i Cuori Lucani.
Agnese Rubino
A Paterno in prima assoluta la terza stagione della Web Serie “Cuori Lucani”
La terza stagione della web serie Cuori Lucani sarà proiettata in prima assoluta il 15 novembre h. 18,30 presso la nuova Bibliomediateca di Paterno, via Mario Pagano, messa cortesemente a disposizione dall’Amministrazione cittadina. Saranno presenti in sala anche Regista e attori.
La terza stagione di Cuori Lucani è dedicata agli sport: climbing, equitazione, trekking, pesca sportiva, ciclocross. Sport rispettosi dell’ambiente che possono essere praticati nella meravigliosa cornice naturale della Val d’Agri.
Cuori Lucani – terza stagione segue altre produzioni video realizzate nell’ambito del progetto Cuore Basilicata che hanno riscosso consenso tra il pubblico e la critica, visibili su questo sito nella sezione Media: Due Ma Non Due e Cuori Lucani, stagioni 1 e 2.
Due Ma Non Due ha vinto il LOG TO GREEN MOVIE AWARD nell’ambito del FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA ed è entrato nella SELEZIONE UFFICIALE della rassegna VISIONI DAL MONDO – Milano.
Cuori Lucani – prima e seconda stagione, nei Festival internazionali:
Award winner: Roma Short Film Festival, Roma; Tuscany Web Fest, Pisa; Apulia Web Fest, Bari Finalista: Web Series Festival, Hollywood (USA); Vesuvius International Film Fest, Napoli Selezione Ufficiale:Lift-Off Filmmaker Session, London (UK); Golden Short Film Festival, Avezzano; Amsterdam Short Film Festival, Amsterdam (NL) First-Time Filmmaker Session, London (UK)
Appuntamento il 15 Novembre a Paterno!
A pasta ‘co capuliatu
Può capitare che all’improvviso vi arrivino ospiti a sorpresa e, allora, preparare una ricetta in poco tempo diventa un’occasione per stare piacevolmente insieme, magari preparando qualcosa di genuino e al contempo sfizioso.
Una ricetta alla quale si può ricorrere in queste occasioni, facendo sicuramente bella figura, è a pasta ‘co capuliatu.
E’ risaputo che i pomodori secchi rappresentino una miniera di sostanze benefiche per l’organismo come sali minerali, e soprattutto licopene.
E’ per questo che propongo oggi la ricetta tradizionale gelese “a pasta ‘co capuliato”, semplice, veloce e molto…salutare!
Ingredienti per 4 persone:
-400g spaghetti (preferibilmente trafilati al bronzo)
-150g di capuliato
-3 spicchi d’aglio
-prezzemolo tritato q.b.
-peperoncino q.b.
-parmigiano q.b.
-olio extra vergine d’oliva q.b.
-sale q.b.
Procedimento:
Soffriggere in un tegame gli spicchi di aglio con olio extra vergine d’oliva
Non appena gli spicchi d’aglio si saranno leggermente imbionditi, aggiungere il capuliato e farlo cuocere a fiamma moderata per pochi minuti
Sminuzzare il prezzemolo con lame taglienti, in modo da preservarne la fragranza.
Nel frattempo far cuocere gli spaghetti, utilizzando preferibilmente un tipo di pasta “ruvida”, in modo da ottenere una giusta emulsione tra pasta e capuliato.
A cottura quasi ultimata, scolare la pasta, prestando attenzione a conservare un po’ di acqua di cottura e aggiungerla al capuliato dopo aver tolto gli spicchi d’aglio.
Mantecare a fuoco basso per alcuni minuti, aggiungendo se necessario qualche cucchiaio di acqua di cottura.
Aggiungere prezzemolo tritato, peperoncino e parmigiano e servire.
Buon appetito!
L'articolo A pasta ‘co capuliatu proviene da Gela Le radici del Futuro.
Andrea Camilleri e il “giorno dei morti”
“Fino al 1943, nella nottata che passava tra il primo e il due di novembre, ogni casa siciliana dove c’era un picciliddro si popolava di morti a lui familiari. Non fantasmi col linzòlo bianco e con lo scrùscio di catene, si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti, il mezzo sorriso d’occasione stampato sulla faccia, il vestito buono stirato a regola d’arte, non facevano nessuna differenza coi vivi. Noi nicareddri, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini (la grandezza variava a seconda dei soldi che c’erano in famiglia) che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio.
Eccitati, sudatizzi, faticavamo a pigliare sonno: volevamo vederli, i nostri morti, mentre con passo leggero venivano al letto, ci facevano una carezza, si calavano a pigliare il cesto. Dopo un sonno agitato ci svegliavamo all’alba per andare alla cerca. Perché i morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e perciò il cesto non lo rimettevano dove l’avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente, bisognava cercarlo casa casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura quando sopra un armadio o darrè una porta scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano paesaggi. Avevo 8 anni quando nonno Giuseppe, lungamente supplicato nelle mie preghiere, mi portò dall’aldilà il mitico Meccano e per la felicità mi scoppiò qualche linea di febbre.
I dolci erano quelli rituali, detti “dei morti”: marzapane modellato e dipinto da sembrare frutta, “rami di meli” fatti di farina e miele, “mustazzola” di vino cotto e altre delizie come viscotti regina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il “pupo di zucchero” che in genere raffigurava un bersagliere e con la tromba in bocca o una coloratissima ballerina in un passo di danza. A un certo momento della matinata, pettinati e col vestito in ordine, andavamo con la famiglia al camposanto a salutare e a ringraziare i morti. Per noi picciliddri era una festa, sciamavamo lungo i viottoli per incontrarci con gli amici, i compagni di scuola: «Che ti portarono quest’anno i morti?». Domanda che non facemmo a Tatuzzo Prestìa, che aveva la nostra età precisa, quel 2 novembre quando lo vedemmo ritto e composto davanti alla tomba di suo padre, scomparso l’anno prima, mentre reggeva il manubrio di uno sparluccicante triciclo.
Insomma il 2 di novembre ricambiavamo la visita che i morti ci avevano fatto il giorno avanti: non era un rito, ma un’affettuosa consuetudine. Poi, nel 1943, con i soldati americani arrivò macari l’albero di Natale e lentamente, anno appresso anno, i morti persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavano, felici e svegli fino allo spàsimo, i figli o i figli dei figli. Peccato. Avevamo perduto la possibilità di toccare con mano, materialmente, quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva preceduto e “stampato”, come in questi ultimi anni ci hanno spiegato gli scienziati. Mentre oggi quel filo lo si può indovinare solo attraverso un microscopio fantascientifico. E così diventiamo più poveri: Montaigne ha scritto che la meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà, perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servire”.
fonte articolo: da Racconti quotidiani di Andrea Camilleri
L'articolo Andrea Camilleri e il “giorno dei morti” proviene da Gela Le radici del Futuro.
Nasce Macchitella Lab, un polo aperto alla formazione e alla innovazione
Macchitella Lab è il risultato della rinascita e trasformazione dell’ex Casa Albergo dell’Eni a Gela, una struttura costruita all’inizio degli anni Sessanta nel cuore del quartiere di Macchitella per ospitare il personale dell’Eni.
L’edificio, completamente riqualificato e ristrutturato, firmato dagli architetti Vincenzo Castellana e Rosanna Zafarana, è stato ceduto da Eni in comodato d’uso al Comune di Gela per due anni, con possibilità di proroga. I lavori, dal valore di circa tre milioni di euro, sono stati interamente finanziati attraverso i fondi delle compensazioni industriali dovute per la città. Riqualificata anche l’area esterna.
Oggi Macchitella Lab diventa un polo aperto a formazione, imprenditorialità, innovazione giovanile e rigenerazione sociale, con ambienti di coworking, laboratori, spazi per start up.
Eni e il Comune di Gela sono affiancati nello sviluppo del progetto anche dall’Università Kore di Enna, da Sicindustria e dalla Fondazione Enrico Mattei.
“Questo iconico immobile, dopo un lungo percorso, a tratti anche complesso, diventa finalmente disponibile e fruibile per tutta la comunità”, ha affermato Walter Rizzi, in rappresentanza della Bioraffineria di Gela Enilive. “Macchitella Lab sarà un polo polifunzionale al servizio di tutta la cittadinanza. Segno tangibile dell’impegno di Eni verso il territorio, in particolare verso le nuove generazioni”.
Per il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, Macchitella Lab “era un impegno della nostra amministrazione: da qui partiranno corsi universitari, incubatori d’impresa e attività per i giovani e incarnerà il simbolo di una città che non vuole arrendersi. Macchitella Lab sarà il punto di riferimento per chi vuole investire su sé stesso e sul proprio territorio, sviluppando idee e innovazioni per creare il proprio futuro”.
Foto: Archilovers.com
L'articolo Nasce Macchitella Lab, un polo aperto alla formazione e alla innovazione proviene da Gela Le radici del Futuro.
Il Centro di Educazione Ambientale Oasi Bosco Faggeto “un’aula a cielo aperto”
“Quando la storia di un luogo si interrompe anche la sua anima rischia di scomparire. Le storie dei luoghi che hanno un’anima vanno ripristinate per farli vivere con la comunità”. Queste le parole del sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, sulla riapertura dopo un fermo di 7 anni, del CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) “Oasi Bosco Faggeto”, un evento positivo per Moliterno, per il territorio e per il Parco Nazionale Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
L’Oasi Bosco Faggeto di Moliterno è un luogo dall’anima millenaria, attraversarlo significa entrare in una cattedrale verde, dove gli alberi altissimi, antichi, immobili, sussurrano storie dimenticate.
La faggeta, una delle più estese e suggestive della Basilicata, nel cuore del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, si presenta in tutta la sua maestosità con un sottobosco mosaico vivente di felci e muschi che fanno da scrigno, tra la primavera e l’inizio dell’estate, a piccole meraviglie, gioielli nascosti tra erba e foglie, le Orchidee Spontanee. Minuscole, delicate, perfette, se ne trovano una decina di specie, alcune rarissime, tutte diverse per forma, colore e habitat. Per riconoscerle serve tempo, pazienza e occhio attento, è la natura che ci ricorda quanto sia importante rallentare per poter vedere davvero.
Ma l’Oasi non è solo natura, è anche memoria, è la voce dei pastori che un tempo attraversavano questi sentieri, le tracce di antiche transumanze, i muretti a secco che raccontano di mani pazienti e vite semplici. Ogni stagione offre qualcosa di unico: l’autunno accende i colori del bosco di toni caldi e struggenti, l’inverno lo avvolge in un silenzio candido e ovattato, la primavera lo risveglia con mille voci e l’estate lo rende rifugio fresco per chi cerca sollievo dal caldo.
Chi attraversa il Bosco Faggeto con passo lento e mente aperta, non può rimanere indifferente alla sua fragilità. È un ecosistema prezioso che oggi più che mai ha bisogno di essere ascoltato, rispettato e protetto. A Moliterno questo impegno ha un nome e un volto: CEAS “Oasi Bosco Faggeto”.
Il Centro di educazione ambientale è stato istituito nel 2005 e la sua sede è la ex Casa Cantoniera nell’area SIC, nei pressi del Bosco Faggeto di Moliterno, sulla S. P.103.
Gestito dalla Cooperativa META, accreditata già dal 2006 quale centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, si pone come obiettivo la promozione di una cultura ecologica profonda e partecipata.
Il CEA è un presidio attivo sul territorio che attraverso laboratori, escursioni guidate, progetti per le scuole e iniziative rivolte ai visitatori, trasforma l’esperienza nel bosco in una occasione concreta di consapevolezza che la natura non è un servizio ma è maestra. E camminando tra i faggi possiamo tornare, forse, un po’ più umani, un po’ più custodi, un po’ più parte del tutto.
La cooperativa, che gestisce l’intera area dell’Oasi Bosco Faggeto, è adesso pronta ad accogliere scuole e gruppi di turisti e grazie alla disponibilità di camere da letto, organizzate al piano superiore della ex casa cantoniera, potrà ospitare campi estivi residenziali, gruppi Scout, escursionisti, anche in sinergia con altre associazioni.
Il sindaco Rubino durante l’inaugurazione ha descritto l’Oasi del Bosco Faggeto come “un contesto ambientale di grandissimo pregio dove si respira la tranquillità dei nostri luoghi e la bellezza della natura dove, soprattutto i più piccoli, possono avere quelle nozioni di educazione ambientale che servono per il rispetto del Creato e per un nuovo stile di vita sostenibile” ed ha affermato che “Grazie alle attività promosse dalla cooperativa che gestisce il CEA si può far partire un nuovo modo per vivere i nostri comuni, per attrarre turisti, visitatori, esperti che si occupano di Orchidee spontanee che qui trovano un habitat eccezionale”. Infatti il centro ospita la sede regionale del GIROS (Gruppo Italiano Ricerca sulle Orchidee Spontanee), collabora a studi e monitoraggi delle orchidee nel territorio anche in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata e con l’Università di Napoli e, dal giorno della inaugurazione, ospita una mostra inedita di fotografie sulle orchidee spontanee del Bosco Faggeto di Moliterno.
Sull’importanza di strutture come il CEA è intervenuta, durante la cerimonia di riapertura, anche la Dott.ssa Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente e Transizione Energetica della Regione Basilicata, parlando dell’Oasi Bosco Faggeto lo ha definito “una vera e propria aula a cielo aperto in cui educare alla tutela, al rispetto ed alla conservazione della biodiversità”.
Il Presidente del Parco Appennino Lucano Antonio Tisci ha ricordato “Il CEA si inserisce nei progetti che abbiamo fatto e stiamo facendo per portare anche i ragazzi a visitare le unicità ambientali ed ecosistemiche del territorio del Parco”.
L’Oasi Bosco Faggeto di Moliterno rappresenta un luogo dove poter ritrovare il senso del tempo, della natura e della bellezza autentica e il CEAS si prende cura di questo incontro con il Creato accompagnando, passo dopo passo, verso un mondo più consapevole.
Agnese Rubino
Foto: Agnese Rubino
Polifoto
Santa Maria dell’Aspro e il frate “ribelle tranquillo”
Ci sono luoghi che non si visitano, si vivono. Luoghi dove il tempo non è nemico ma compagno.
Nel cuore della Basilicata, incastonata tra le vette del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese, si apre una terra di silenzi profondi, di boschi che respirano con te, di paesi aggrappati alle rocce e di storie sussurrate dal vento, la Valle dell’Agri. È qui che il turismo lento trova la sua voce più autentica. Camminare in Val d’Agri non è solo muoversi, è ascoltare, ritrovare il ritmo del proprio passo, il battito del proprio cuore e il senso della presenza.
Scegliere la Val d’Agri per un viaggio lento non è una moda ma una necessità dell’anima. In un mondo che corre qui si rallenta, si cammina, si respira, si osserva, si parla e soprattutto si ascolta. Destinazione ideale per escursionisti, pellegrini, viandanti moderni, ma anche per chi semplicemente ha bisogno di riscoprire la bellezza delle cose semplici.
Camminare in Val d’Agri è imparare che viaggiare non è arrivare ma restare in un luogo, con la mente, con il cuore, con la memoria. E quando si ritorna a casa qualcosa di questa terra rimane, il profumo dei boschi, il rumore delle foglie calpestate lungo i sentieri, una promessa lasciata alla montagna.
Il turismo lento qui è una necessità perché solo rallentando si può cogliere il vero significato dell’essere accolti da una terra che non ha bisogno di gridare per farsi notare, è un modo diverso di guardare il mondo, è scegliere strade secondarie invece che autostrade.
Non serve andare lontano per perdersi nel bello.
Qui il tempo non scorre con le lancette ma con il passo lento dei viandanti e il respiro quieto della terra. È il tempo del cammino, quello che riconnette l’anima al paesaggio e da voce a luoghi dimenticati. E proprio in uno di questi angoli sospesi tra storia e silenzio, sorge il Monastero Francescano di Santa Maria dell’Aspro, nel borgo di Marsicovetere, nascosto tra le pieghe della Basilicata più autentica.
Tra le colline che sfumano nel verde e le pietre che raccontano storie antiche, il pellegrino moderno ritrova qualcosa di prezioso: la meraviglia della lentezza, il senso dell’attesa e quella fragile bellezza che solo i luoghi fuori dal tempo sanno donare. Il monastero di Santa Maria dell’Aspro, ex Convento di Santa Maria di Loreto, non è un luogo da visitare, ma da raggiungere con rispetto, non si guarda, ma si ascolta, perché è molto di più di una semplice tappa, è un incontro. Quando si sale lungo le pendici del monte Volturino, sul sentiero che da Villa d’Agri (frazione di Marsicovetere) porta al Convento, il paesaggio si apre su spazi verdi, ulivi nodosi, arbusti di ginestre, rocce spoglie.
Il rumore del mondo si affievolisce passo dopo passo, lasciando spazio al respiro della natura, al fruscio del vento tra le fronde, al battito del cuore che si fa eco tra le colline. Il silenzio cresce e ci si ritrova sospesi nel tempo, tra rovine, frammenti di pietra, segni di restauri recenti. Non è solo un cammino fisico, ma interiore, ogni passo verso il convento invita a rallentare, a contemplare la meraviglia del Creato nel panorama che, in un tramonto, si fa pittura e preghiera. Santa Maria dell’Aspro appare all’improvviso, discreta e raccolta, quasi volesse farsi trovare solo da chi davvero la cerca, e non colpisce con la grandiosità ma con la sua sacralità silenziosa. È una chiesa che sembra nata dalla terra stessa, una continuazione naturale del paesaggio, fatta della stessa pietra che ha visto generazioni pregare, sognare, sperare. Il suo nome “Aspro”, parla di asprezza forse del terreno su cui è sorta nel XII secolo, forse delle vite che qui si sono intrecciate nei secoli. Ma in questa parola c’è anche la forza, la tenacia della fede popolare, la dolcezza nascosta tra le rughe del tempo.
La presenza Francescana in Basilicata è viva a partire dagli anni 30-40 del XIII secolo, l’ordine religioso francescano con le sue quattro famiglie dei Conventuali, degli Osservanti, dei Riformati e dei Cappuccini è quello maggiormente diffuso, e sul finire del 1200 e l’inizio del 1300 sorgono i primi insediamenti avviati alla stabilità conventuale in alcuni centri della regione. Non mancano in territorio lucano, stazioni eremitoriali, due di queste si trovano proprio in Val d’Agri: San Michele presso Saponara (Grumento Nova) e Santa Maria dell’Aspro presso Marsicovetere.
E qui, sul pendio della Valle dell’Agri è custodita ancor oggi l’eco di una voce, quella di Angelo Clareno, frate “ribelle tranquillo” che fece del Monastero di Santa Maria dell’Aspro il suo ultimo rifugio. Al secolo Pietro Chiarino, fu l’esponente di spicco del movimento degli Spirituali che attraverso una interpretazione molto rigida della regola francescana, aspiravano ad una vita ascetica, povera, particolarmente austera ed intransigente. Per i canonisti del ‘300 gli Spirituali sono una sorta di setta eretica e per questo, nel 1334 il Papa Giovanni XXII ordina la cattura di Clareno per sottoporlo a giudizio. Il frate riesce a darsi alla fuga ma bisognava individuare un luogo sperduto e difficile da raggiungere e, in pieno ‘300, il sud Italia è il luogo ideale per offrire rifugio ad un perseguitato.
È così che la Valle dell’Agri, a quel tempo inaccessibile e selvaggia, si offrE quale luogo ideale ad Angelo Clareno che, dopo una vita di privazioni e austerità, ferma la sua fuga nell’eremo di Santa Maria dell’Aspro presso Marsicovetere. Il motivo per cui si ferma proprio in questo luogo ci è ignoto, come anche l’itinerario del suo viaggio, ciò che rimane della vicenda sono le notizie circa il soggiorno in Val d’Agri di questo frate dalla figura controversa e affascinante. L’ambiente umano e naturale che caratterizza questi luoghi è il terreno fecondo dove si innestano le radici di queste esperienze eremitiche e mistiche. Se per l’eremita era importante la salute dello spirito più di quella del corpo, la guarigione dalle malattie era il desiderio degli abitanti dei luoghi limitrofi a Santa Maria dell’Aspro, del popolo minuto composto soprattutto d contadini e pastori. Stando ai testi agiografici sul Clareno la popolazione della Val d’Agri soffriva di diverse patologie agli occhi, alle braccia, alle gambe ed alla gola, oltre ad essere flagellata da tumori di ogni tipo. Secondo i documenti il frate spirituale guarì un bambino di Satriano, un piccolo lebbroso di Saponara e un ragazzino di Montemurro. L’intervento del Clareno fu miracoloso per guarire piaghe, fistole e ingrossamento dei linfonodi come nel caso di un muratore di Viggiano che si recò all’eremo per ottenere l’imposizione delle mani. Il frate, per non dare di sé l’immagine del taumaturgo, si rifiuta più volte ma poi, convinto dall’insistenza del malato, lo toccò determinando la scomparsa della malattia. Clareno muore nell’eremo alle pendici del monte Volturino nel 1337, e benché nel tempo la memoria materiale sia svanita, di lui restano questi preziosi ricordi a testimonianza di una pagina affascinante del francescanesimo lucano che accolse una delle figure straordinarie del ‘300, uno degli uomini più ammirati e più denigrati di quel tempo, uomo di grande cultura che dopo aver vissuto ad Avignone negli anni della corte papale, girovagato per l’Italia, perseguitato e fuggitivo, termina la sua esistenza in questo luogo remoto nell’interno della Basilicata tra boschi selvaggi e silenzi profondi, luogo di vita ascetica e severa.
Sebbene qui il tempo sembrI essersi fermato, nel 2008 ha avuto inizio una campagna di recupero del Monastero, è stata rinvenuta la pavimentazione originale e negli ultimi anni è stato possibile il recupero della Chiesa e delle mura grazie all’opera di restauro del Comune di Marsicovetere.
Visitare oggi Santa Maria dell’Aspro è un “pellegrinaggio lento” e non serve necessariamente essere credenti per essere avvolti dal fascino di questo luogo.
Visitare luoghi come questo significa onorare la lentezza, restituire valore alla storia, al tempo, alla spiritualità. È un turismo che non consuma ma accarezza, che non prende ma riceve, non fotografa soltanto ma affascina e contempla.
Agnese Rubino
Foto: Pellicoro, Alessio(https://dati.beniculturali.it)
Wikipedia
Parrocchia Villa d’Agri B.V. Addolorata
La fantastica storia di Francesco Ferramosca, musicista di Viggiano
Francesco Ferramosca (nato il 23 agosto 1893) era un violinista professionista di Viggiano che emigrato a Johannesburg , Sud Africa, salì alla ribalta negli anni ’10 del ‘900 come uno dei violinisti più talentuosi del paese. Primi anni di vita
Francesco era il quinto figlio di Giuseppe Ferramosca e Agnese Mariarosa Miraglia. A parte due figli morti in giovane età, lui e i suoi tre fratelli rimanenti erano tutti musicisti di talento a Viggiano. Iniziò a studiare violino all’età di sei anni e ben presto mostrò grandi doti. Tuttavia, dopo alcuni anni contrasse la tubercolosi e la sua salute peggiorò. Fu allora che suo padre decise di portarlo in Sudafrica, noto per il suo clima secco e per le strutture dedicate alla cura della tubercolosi. La famiglia aveva contatti con diversi musicisti italiani a Johannesburg, così Giuseppe portò Francesco e suo fratello Nicola a Johannesburg intorno al 1907 per cercare cure per lui. Francesco fu affidato elle cure degli amici e suo padre e suo fratello tornarono a Viggiano.
CarrieraDurante le cure, Francesco continuò a studiare violino. A quei tempi, Johannesburg assomigliava a un campo minerario invaso dalla vegetazione, con pochissimi grandi edifici circondati da case comuni. C’era poco lavoro fuori dalle miniere e quasi nulla per un giovane musicista. Francesco fu ridotto a suonare per strada per pochi centesimi, ma quello si rivelò l’inizio della sua carriera. Nel 1908, un rinomato trio musicale d’oltremare composto dai tre fratelli Cherniavsky, Leo (violino), Mischel (violoncello) e Jan (pianoforte), era in tournée in Sudafrica. Videro Francesco esibirsi per strada e rimasero così colpiti dal suo timbro e dal suo virtuosismo che trascorsero mesi ad allenarlo e a perfezionare la sua tecnica. Questo alla fine portò Francesco a unirsi a un trio con Lorenzo Danza al pianoforte e Reuben Goldberg al violoncello. Il trio divenne molto popolare e suonò in locali in tutto il Reef , Pretoria , e nella vicina Lourenço Marques (ora Maputo ), Mozambico , così come a matrimoni mondani.
Orchestra Ferramosca al Waldorf Cafe, Città del Capo, 1925Durante i suoi concerti, incontrò Doris Gwendoline Helliwell , un’affermata pianista concertista, che in seguito lo accompagnò in diverse occasioni. Francesco sposò Doris e ebbero due figli, Joseph Frederick Lorenzo (“Genzie”) Ferramosca e Frank Eugene (“Chickles”) Ferramosca.
Il trio suonava regolarmente al Balcony Tea Room di Johannesburg . Negli anni successivi, il trio si espanse fino a diventare un’orchestra di sette elementi (“Orchestra Ferramosca”), con Francesco come leader. Nel 1920 Francesco era riconosciuto come il miglior violinista del paese. Nel giugno del 1924, partì con la sua famiglia per un breve tour in Italia, e un “comitato influente” organizzò per lui un concerto di beneficenza, con un “programma musicale molto attraente”.
Nel 1925 a lui e alla sua orchestra fu offerto un posto fisso al Waldorf Cafe , Città del Capo e decisero di trasferirsi con la sua famiglia a Mouille Point . Mentre era a Città del Capo, si esibì con la Cape Town Symphony Orchestra in diverse occasioni. Dopo tre anni, tornò a Johannesburg all’inizio del 1928, dove si esibì con la Johannesburg Symphony Orchestra e suonò serate alla sala da tè OK e infine al Rondi’s. L’orchestra fu la prima a trasmettere da una sala da tè, avendo uno spazio regolare di mezz’ora sulla stazione radio locale SABC.
Francesco con i suoi due figli, Frank e Lorenzo, Johannesburg, 1929 Vita successivaL’aria umida e il maltempo a Città del Capo ebbero un effetto dannoso sulla salute di Francesco e la sua tubercolosi riemerse. Dopo il ritorno a Johannesburg, la sua salute peggiorò significativamente e dopo alcuni mesi fu ricoverato in isolamento presso il Sanitarium di Nelspoort [8] nel deserto del Karoo , rinomato per il trattamento della tubercolosi. Fece buoni progressi e tornò a Johannesburg nell’ottobre del 1928 per riprendere la sua carriera. Tuttavia, gli orari strani e l’atmosfera fumosa ebbero il loro peso e trascorse altri tre mesi a Nelspoort. Tornò a Johannesburg, ma poco dopo soccombette a un mal di gola e morì nel maggio del 1932 all’Hillbrow General Hospital. È sepolto al cimitero di Westpark, Johannesburg.